PianALTO - Il territorio in cui vivi - Luogo ricco di eccellenze ma ancora poco conosciuto
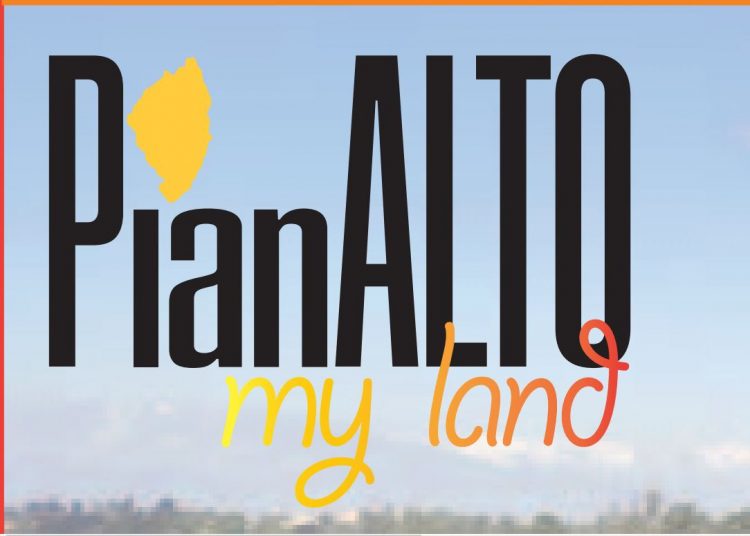
► Il ciclo dell’acqua nel Pianalto: l’importante ruolo delle peschiere (17/04/2024)
Importante elemento di sviluppo del Pianalto è l’utilizzo razionale della risorsa idrica.
Nel Bacino della Banna – il più grande in sponda destra del Po – la gestione del ciclo integrato dell’acqua nel corso dei millenni e nell’Ottocento ha creato le condizioni per dare la prima forma a un distretto del cibo del Chierese-Carmagnolese che oggi è tornato di attualità. Perno della rete, oggi come allora, è il fiume Banna, insieme al suo parallelo Tepice. La Banna scorre da Buttigliera d’Asti, Villanova, Poirino, Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri fino al Po. Lungo il suo percorso raccoglie le acque che cadono per precipitazioni nel grande ventaglio delle colline del Monferrato e del Roero che corre dal Rio Sauglio alla Gora del Mulino Nuovo di Carmagnola. Queste acque servivano per irrigare i campi coltivati a ortaggi, canapa, foraggio, granaglie e legume, le piantagioni di pioppi, gelsi, alberi da frutta e salici e per abbeverare il bestiame. Nel bacino idrografico della Banna numerosi erano i mulini tra Carmagnola, Villastellone, Poirino, Chieri, Santena, Cambiano e Trofarello. Oltre a macinare mais, grano, segale, l’acqua serviva come forza motrice per il tessile, la meccanica, la siderurgia, il cartario, la conceria delle pelli, la pesta della canapa, la metallurgia, la molitura, la lavorazione del legno e del ferro, il trasporto di merci. Un reticolo impressionante, faticosamente costruito nei secoli. Efficiente ancora oggi sebbene bisognoso di manutenzione ed investimenti.
Acqua, da queste parti, ha sempre significato benessere e lavoro e perciò era raccolta, conservata e convogliata con mille attenzioni e accorgimenti. Grondaie, scoli, canaletti, fossi finivano in cisterne e pozzi per il consumo famigliare. Il resto era raccolto in peschiere e invasi naturali o artificiali che servivano durante i periodi di siccità. L’acqua, scaldata sul fuoco, era usata da più membri della famiglia per lavarsi e la stessa mezza botte serviva anche per fare il bucato con la cenere e poi per il risciacquo col sapone. L’acqua era rispettata e mai sprecata. Il ciclo integrato iniziava dalla pioggia e finiva col versamento dell’acqua sporca nei solchi dell’orto. La più fetida finiva nell’angolo del cortile dove la letamaia costituiva un importante elemento per la vita delle famiglie. Nelle letamaie, oltre agli scarti alimentari, finivano le urine e le feci degli animali e delle persone. La neve aveva un valore aggiunto perché il freddo prodotto dal ghiaccio, lavorato nelle ghiacciaie, era impiegato nella conservazione alimentare e nel lenire le febbri. Persone e animali, nel corso dei secoli, si erano integrati nell’ambiente dando vita a un sistema che è durato fino a metà del Novecento. Certo non erano tutte rose e fiori, anzi. L’acqua era molto pericolosa. Trasportava malattie e morte, causate dalle condizioni igieniche e da carestie portate da siccità e da alluvioni. Le febbri tifoidee erano tra le principali cause di morte. Colpa della vicinanza dei pozzi alle letamaie. La malaria con i suoi eccessi di febbre uccideva chi lavorava in zone di acqua stagnante. Il ciclo integrato dell’acqua è alla base del SIC IT1110051 “Peschiere e Laghi di Pralormo”, Sito di Importanza Comunitaria inserito nell’elenco dei siti appartenenti alla Regione Biogeografica Continentale, approvati ed adottati con Decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, sostituita dalla più recente Decisione di esecuzione (Ue) 2018/43 della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Il sito è stato istituito per mantenere lo straordinario patrimonio di stagni e peschiere che rivestono un notevole interesse per la conservazione di tutte specie legate agli ambienti acquatici, in primis di alcune specie floristiche rare e per gli anfibi inseriti negli allegati della Direttiva Habitat, ma anche per i ricchi popolamenti di Odonati (libellule) e di altri invertebrati acquatici. Ne consegue che la conservazione degli stagni, il ripristino di quelli in cattivo stato di conservazione e la realizzazione di nuovi invasi gestiti a favore della biodiversità, è la prima finalità gestionale per il Sito, in quanto habitat riproduttivi obbligati delle specie di interesse.
► I segreti del topinambur (ciapinabò): un tubero dimenticato ma utilissimo (24/01/2024)
Parlano del topinambur come un tubero ormai dimenticato: se poche persone lo conoscono come alimento, sono ancor meno quelle che gli attribuiscono una certa importanza fitoterapica.
Il topinambur è una pianta perenne erbacea originaria del Nord America (Canada in particolare), abbastanza apprezzata anche in Italia per l’alimentazione umana e, soprattutto, per il bestiame. A colpo d’occhio, il topinambur può essere scambiato per una patata più globosa e dura: le differenze con il tubero per antonomasia non finiscono qui. Infatti, il topinambur è meno nutritivo rispetto alla patata, oltre a contenere una quantità importante di inulina, a scapito dell’amido. E’ quindi particolarmente indicato in sostituzione della sua parente stretta nei menù dei diabetici.
Perché questo strano nome?
Secondo la nomenclatura di Linneo, il topinambur è Helianthus tuberosus; volgarmente, viene chiamato anche tartufo di canna (per l’affinità di forma), patata del Canada, carciofo di Gerusalemme (per l’affinità di gusto) o, ancora, rapa tedesca (malgrado non abbia nulla a che vedere con le rape di qualsivoglia nazionalità. Il nome scientifico bizzarro e singolare richiama un particolare comportamento del fiore di topinambur: il genere (Helianthus) rimanda a “sole” (helios, in greco), e “fiore” (anthos nella lingua greca). L’accostamento delle parole si riferisce alla propensione dei fiori a protendersi verso il sole (eliotropismo).
Il topinambur appartiene alla famiglia delle Compositae Tubuliflorae: è una pianta erbacea perenne il cui fusto può raggiungere i 2 o 3 metri d’altezza e, nella parte apicale, si presenta ispido. Le foglie sono sia alterne che opposte: nella parte più bassa del fusto sono in genere alterne, mentre quelle opposte si riscontrano nella parte sovrastante; ancora, le foglie, molto acuminate ed appuntite, presentano margine seghettato e superficie ruvida di color verde scuro, rigato da marcate nervature. I fiori gialli, similmente ai girasoli, si rivolgono al sole, seguendone il cammino con i capolini: non a caso, i fiori di topinambur vengono spesso scambiati, appunto, per girasoli.
Il topinambur viene coltivato per la radice tuberizzata (le radici sono molto ramificate e sono provviste di rizomi tuberiferi): essa è globulosa, presenta una forma tozza ed è avvolta da una pellicola piuttosto rigida e chiara. La pianta di topinambur è molto rustica e si adatta a tutti i climi, nonostante prediliga quelli temperati-caldi. I topinambur sono costituiti da una buona quantità di acqua (80%), 15-20% di glucidi (tra cui fruttosio, capace di non gravare sull’attività pancreatica), 2% di vitamina A e tracce di vitamine del gruppo B, Sali minerali (ferro, potassio, silicio, fosforo, magnesio) e aminoacidi quali asparagina ed arginina sono inoltre fonte di vitamina H (biotina) importantissima nella prevenzione di stanchezza fisica, dolori muscolari ed inappetenza.
Come cucinare il topinambur?
Il topinambur viene generalmente preparato secondo le medesime modalità delle patate: può essere bollito in abbondante acqua salata o, ancor meglio, cotto a vapore, prestandosi così alla preparazione di gustosi – e nel contempo semplici – contorni; in alternativa, può essere anche cucinato in padella o fritto. Dopo la cottura, sia questa in acqua, in padella, in forno o nell’olio, il sapore del topinambur risulta delicato e dolciastro. Tra le ricette più famose a base di topinambur ricordiamo: il risotto al topinambur e il flan di topinambur.
E’ un ortaggio che nelle nostre zone e’ particolarmente presente nell’area di Carignano che ogni anno gli dedica una sagra (inizio di ottobre) dove lo si può degustare cucinato secondo varie ricette. Le sagre degli anni 2022 e 2023 sono state particolarmente attrattive ed in molti si sono fermati a degustare negli stand le pietanze a base di questo ortaggio. Sebbene infatti la sua piena stagione sia ottobre lo si degusta bene anche nei successivi mesi invernali.
► Deposito nazionale di scorie nucleari. Cosa occorre sapere? Dove si farà? (10/01/2024)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’elenco delle aree nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico, al fine di stoccare in via definitiva i rifiuti radioattivi di bassa e media attività. La Carta è stata elaborata dalla Sogin sulla base delle osservazioni emerse a seguito della consultazione pubblica e del Seminario nazionale condotti dopo la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), e approvata dall’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin). La Cnai individua 51 zone i cui requisiti sono stati giudicati in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per questo tipo di strutture.
Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, presentare la propria autocandidatura a ospitare il Deposito nazionale e il Parco tecnologico e chiedere a Mase e Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso.
I 51 siti sono raggruppati in 5 zone ben precisi e sono distribuiti su 6 regioni: Piemonte (5 siti), in provincia di Alessandria, nei comuni di Bosco Marengo, Novi Ligure, Alessandria, Oviglio, Quargnento, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Fubine Monferrato. E’ stata invece definitivamente scartata Carmagnola; Lazio (21 siti idonei), nel viterbese, nei comuni di Montalto di Castro, Canino, Cellere, Ischia di Castro, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Corchiano, Gallese, Tarquinia, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano; Sardegna (8 siti), fra le province di Oristano e di Sud Sardegna, a Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgius Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus, Guasila; fra Puglia e Basilicata 15 siti: in provincia di Matera (Montalbano Jonico, Matera, Bernalda, Montescaglioso, Irsina) e i comuni di Altamura, Laterza e Gravina, con una appendice nel Potentino, a Genzano di Lucania; Sicilia (2 siti idonei) nel trapanese, con aree idonee a Calatafimi, Segesta e Trapani.
Perché è necessario un deposito nazionale. L’Unione Europea (articolo 4 della Direttiva 2011/70) prevede che la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi avvenga nello Stato membro in cui sono stati generati. La maggior parte dei Paesi si è dotata o si sta dotando di depositi per mettere in sicurezza i propri rifiuti a molto bassa e bassa attività. Per sistemare definitivamente i rifiuti a media e alta attività, alcuni Paesi, tra cui l’Italia, hanno la possibilità di studiare la localizzazione di un deposito profondo (geologico) comune in Europa allo scopo di fruire dei potenziali vantaggi di una soluzione ottimizzata in termini di quantità di rifiuti, costi e tempi di realizzazione.
Il Deposito nazionale è necessario per smaltire i rifiuti radioattivi a bassa e bassissima attività, attualmente stoccati in depositi temporanei nei siti degli impianti nucleari disattivati, dove Sogin sta portando avanti mantenimento in sicurezza e decommissioning. Al Deposito nazionale confluiranno anche i rifiuti attualmente stoccati in depositi temporanei non gestiti da Sogin, che provengono da fonte non energetica, ossia quelli derivanti dalla ricerca, dall’industria e dalla medicina nucleare, che continuano inevitabilmente ad essere prodotti anche in Italia.
La maggior parte dei rifiuti radioattivi in Italia è costituita da rifiuti a basa o bassissima radioattività.
In Piemonte sono stati individuati i 5 siti nell’alessandrino… Trino vercellese è l’unico Comune autocandidatosi ad accogliere il sito nazionale che consentirebbe la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti che ancora residuano dalla ex-centrale nucleare.. La localizzazione del sito unico sarà decisa nei prossimi mesi. Carmagnola ha scampato il pericolo… continueremo ad occuparcene…
► «Nun c’è trippa pe’ li gatti», l’origine di un alimento «da leccarsi i baffi» (22/11/2023)
Il famoso detto romano nun c’è trippa pe’ li gatti è stato coniato verso i primi del ’900 dal primo cittadino di Roma dell’epoca Ernesto Nathan, allorché si accingeva a rivedere alcune spese “superflue” del bilancio delle spese di Roma.
Una voce tra tante lo colpì: “spesa per il mantenimento di una colonia di felini randagi” e venne da allora cancellata dai bilanci comunali… da allora il detto nun c’è trippa pe’ li gatti appunto.
A Milano la busecca, come viene chiamata in milanese, è considerata talmente emblematica che l’epiteto busecconi cioè “mangia-trippa” è divenuto una denominazione scherzosa dei milanesi stessi.
Il termine trippa (di etimologia incerta forse dal francese e dall’inglese tripe a sua volta di origine celtica tripa correlato con il gaelico tarp “mucchio, cumulo”, indica una frattaglia usata in gastronomia e ricavata da diverse parti dei prestomaci del bovino e non, come molti credono, dall’intestino.
Nei bovini adulti, lo stomaco è composto da quattro cavità distinte ovvero tre prestomaci di origine esofagea più uno stomaco ghiandolare simile come funzionalità al nostro: il rumine, (la parte più spessa e grassa della trippa), il reticolo, l’omaso, l’abomaso e il duodeno. Quest’ultimo è il taglio tradizionale della trippa di Moncalieri.
La trippa è un alimento conosciuto e consumato da lungo tempo: i greci la cucinavano infatti sulla brace mentre i romani la utilizzavano per preparare salsicce. Oggi la trippa costituisce un alimento tradizionale di molte regioni d’Italia, in particolare della cucina povera veneta, romana, toscana, genovese e milanese, e viene consumata tagliata a strisce e preparata in maniere diverse. Per lo più la trippa viene venduta già lavata e parzialmente cotta, e richiede poi ulteriore tempo di cottura sia per acquistare la giusta morbidezza sia per potersi impregnare degli aromi che le conferiscono un sapore appetitoso; può anche essere consumata condita con olio, sale, pepe e limone senza ulteriore cottura.
I piatti tipici della tradizione gastronomica italiana a base di trippa sono: Trippa alla genovese – in umido con fagiolame o patate, in brodo (Sbïra che era l’antico ultimo pasto dei condannati a morte della Repubblica di Genova), cruda in insalata, olio sale pepe e limone, con sugo e pinoli, e molte altre ricette.Trippa alla piacentina (e alla milanese) (büśecca) – in umido con salsa di pomodoro e fagioli bianchi di Spagna. Trippa di Moncalieri – trippa pressata a forma cilindrica, della gastronomia piemontese. Trippa alla fiorentina – al tegame e accompagnata da salsa di pomodori e parmigiano. Lampredotto – Il popolare lampredotto che viene usato dai trippai fiorentini per preparare il tradizionale panino con salsa verde. Trippa alla romana – con salsa di pomodori, menta romana e pecorino. Morzeddhu catanzarisa (Morzello di Catanzaro) – antichissima pietanza tipica con trippa e frattaglie lungamente consumate nel sugo di pomodoro, peperoncino e altri odori e mangiata nella pitta catanzarisa, caratteristico pane a forma di ciambella. Trippa alla romagnola: in Romagna la trippa viene stufata con soffritto di aglio, cipolla e prezzemolo, conserva di pomodoro e vino bianco e fortemente aromatizzata con scorza di limone, cannella e chiodi di garofano e, infine, spolverata di parmigiano grattugiato nel piatto.Zuppa marescialla – piatto tipico della tradizione povera napoletana, con varie frattaglie (pancia, bonetto, mille pieghe o centopelli, franciata). Anche altri paesi europei consumano la trippa cucinata in modi diversi:
Valori nutrizionali. Contrariamente a quanto si crede la trippa non ha elevato valore nutrizionale rispetto alle altre parti di carne bovina. Tuttavia la sua digeribilità è più faticosa a causa dell’abbondanza di tessuto connettivo elastico, il che la rende sconsigliabile per i giovani soggetti che sono ancora nella prima infanzia. L’elevato contenuto in colesterolo la rende inoltre controindicata agli ipercolesterolemici. Può essere consumata, moderatamente, anche da chi soffre di uricemia o gotta in quanto l’elevata presenza di purine (molto controindicate nelle patologie appena citate) è limitata alla trippa prima della cottura. I valori nutrizionali, per ogni 100 grammi di parte edibile, sono espressi nella seguente tabella. 100 grammi di prodotto finito (una porzione non abbondante contengono 108 chilocalorie):
Concludendo: a meno che non ci siano patologie legate al metabolismo dei grassi, se piace, non c’è alcun motivo per non mangiarla… è così buona…
► L’acqua del bacino del Banna, fonte di vita ma anche di lavoro e benessere (19/7/2023)
La fortuna del Pianalto nell’Ottocento dipese dall’emersione di nuove categorie sociali portatrici di idee e interessi tra le quali i proprietari terrieri, appartenenti a una nobiltà proiettata verso gli investimenti e l’innovazione.
I nuovi attori sociali erano pertanto medi possidenti interessati ad incrementare la produttività delle loro terre, nonché piccoli proprietari, artigiani, operai, professionisti e impiegati desiderosi di trovare, attraverso il lavoro, una collocazione nella società e grandi avversatori delle rendite di posizione occupate dalla vecchia nobiltà, dal clero e dai militari.
L’ascesa delle categorie di cui sopra fu facilitata dalla presenza di acqua e dall’uso razionale che ne fu fatto.
Nel Bacino della Banna – il più grande della provincia di Torino in sponda destra del Po – la gestione del ciclo integrato dell’acqua nel corso dei millenni e nell’Ottocento ha creato le condizioni per il realizzarsi del distretto del cibo del Chierese-Carmagnolese che oggi è tornato centrale nella realtà geografica del Pianalto ed economica del Distretto del cibo.
Il perno della rete idrica di questi territori è il fiume Banna che scorre da Buttigliera d’Asti, a Villanova, Poirino, Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri fino al Po, raccogliendo le acque piovane delle colline del Monferrato e del Roero dal rio Sauglio alla Gora del Mulino Nuovo di Carmagnola.
Queste acque servivano per irrigare i campi coltivati a ortaggi, canapa, foraggio, granaglie e legumi e le piantagioni di pioppi, gelsi, alberi da frutta, salici e boschi nonché per abbeveraggio del bestiame.
Nel bacino idrografico descritto erano molto rappresentati i mulini (tra Carmagnola, Villastellone, Poirino, Chieri, Santena, Cambiano e Trofarello) che, oltre a macinare mais, grano, segale, servivano come forza motrice per il tessile, la meccanica, la siderurgia, il cartario, la conceria delle pelli, la pesta della canapa, la metallurgia, la molitura, la lavorazione del legno e del ferro, il trasporto di merci. Un reticolo impressionante, faticosamente costruito nei secoli ed estremamente efficiente.
L’acqua in queste zone è da sempre sinonimo di benessere, lavoro, pulizia.
Essendo un bene collettivo e prezioso era raccolta, conservata e convogliata con grande accorgimento e perizia. Grondaie, canaletti, fossi finivano
in cisterne e pozzi per il consumo famigliare, il resto era raccolto in peschiere e invasi naturali o artificiali.
I nostri antenati, se ricchi, si servivano di brocche e bacili, riempiti dai servi per le loro abluzioni e la loro igiene personale. Gli altri, la maggior parte, usavano con parsimonia l’acqua raccolta nei secchi o nelle mezze botti che servivano a tutta la famiglia per il “bagno settimanale”. La stessa mezza botte serviva solitamente anche per fare il bucato con la cenere ed i panni venivano poi passati col sapone e risciacquati.
L’acqua come il pane, non si sprecava. Buttarla via era grave come commettere un peccato.
Il ciclo integrato iniziava dalla pioggia e finiva col versamento dell’acqua sporca nei solchi dell’orto.
Le acque più fetide finivano nell’angolo del corti- le dove c’era un’importante zona di “servizio” per la vita delle famiglie: la letamaia.
In tali strutture venivano raccolte, oltre agli scarti alimentari, le feci degli animali e delle persone.
Ma il ciclo dell’acqua proseguiva con la neve che, lavorata e raccolta nelle ghiacciaie, era usata come ghiaccio nella conservazione alimentare e come antipiretico.
Certo molteplici erano gli inconvenienti: l’acqua poteva diventare un veicolo di morte quando trasportando batteri e parassiti determinava il diffondersi di numerose malattie aggravate da condizioni igieniche precarie, siccità, alluvioni, penuria di cibo.
Le febbri tifoidee e le epatiti (che oggi sappiamo di Tipo A) erano tra le principali cause di morte, complici le infiltrazioni dalle letamaie le cui acque potevano percolare e avvelenare i pozzi.
Oggi il ciclo integrato dell’acqua è gestito tramite i Contratti di Fiume. Il contratto di fiume del Ba- cino del Banna è lo strumento con il quale si go- verna la disponibilità, igiene, distribuzione della risorsa acqua. Il Distretto del Cibo, che grosso modo coincide con il territorio del contratto del fiume Banna è lo strumento utile a sostenere le attività delle aziende agricole e dell’agroindustria di zona. Uno strumento che prestando attenzione al paesaggio, all’ambiente, al cambiamento climatico, alla coltivazione di cibo fresco e sano, alla salute dei consumatori, fa coincidere un’identità territoriale con un’identità economica.
►Distretto del Cibo spegne la prima candelina, adesso bisogna superare i campanilismi (28/6/2023)
Il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, che è nato come strumento per la cura degli interessi delle aziende agricole e del settore agroalimentare del territo- rio, ha appena compiuto il primo anno di vita. E’ nato dal basso: le prime ad organizzarsi sono state le aziende agricole nel febbraio
2018. Nel 2021 ha riscosso l’attenzione e l’impegno dei Comuni, della Città metropolitana, della Regione e di Enti e Associazioni territoriali che hanno riconosciuto come finalmente si avviasse un’operazione che costituiva e costituisce un impor- tante atto politico.
Le dimensioni territoriali entro cui il Distretto ope- ra sono più ampie, più funzionali e più realistiche di quelle comunali.
Sia perché le aree di alcuni prodotti agroalimentari travalicano i limiti zonali e provinciali, sia perché gli interessi e le dinamiche del settore agroalimentare spaziano dal livello zonale a livello globale e viceversa, sulla base di input costituiti da processi innovativi, logistici, produttivi, di mercato, di ricerca e sviluppo, di integrazione con altre attività.
Le relazioni zonali sono l’elemento di forza del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese che si caratterizza per la biodiversità delle produzioni, le integrazioni aziendali e per le differenti attività agricole che variano dalla coltivazione di cereali, legumi, ortaggi, frutta, uva, fieni, erbe officinali, vivaismo, allevamento di bestiame per carni, latte e latticini e di insetti per il miele.
Una ricchezza basata sulla presenza di piccole aziende agricole forti nel garantire un alto livello di qualità ma deboli nel realizzare economie di scala nel lavoro, negli approvvigionamenti, nei volumi produttivi e nella commercializzazione.
Il Distretto del cibo è strategico per la produzione di cibi sani, genuini, freschi, che finiscono sulle tavole locali, su quelle torinesi e piemontesi e spesso fuori dal contesto regionale.
Costituisce una realtà paragonabile, con tutti i distinguo del caso, al Roero e alle Langhe la cui forza è stata quella di unire gli intenti e di presentarsi come un unicum in termini di progetti, prospettive, accoglienza turistica, partecipazione a bandi di finanziamenti. In ultima analisi la forza dei nostri cugini blasonati è stata quella di creare un brand.
L’iter potrebbe essere felicemente replicato anche qui individuando quali sono le caratteristiche del territorio e le caratteristiche dei prodotti e delle aziende per ricavare idee da tradurre in progetti a sostegno del necessario cambiamento.
Occorre però superare campanilismi locali e zonali che limitano lo sviluppo sociale della comunità.
Un elemento di sviluppo sicuramente positivo è stata la realizzazione dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del Peperone di Carmagnola, dell’Asparago Santenese, delle Ciliegie di Pecet- to, della Cipolla di Andezeno, del Porro, delle Carni, e del Coniglio Grigio di Carmagnola, del Ciapinabò di Carignano, del DOP della Tinca poirinese, del Pomodoro Costoluto di Cambiano, della Patata di Villastellone, delle Amarene e del Pomodoro cuore di bue di Trofarello sostenuti da una orticoltura specializzata che lavora 12 mesi all’anno come testimoniano le numerosissime sagre e fiere paesane che si coagulano e si organizzano intorno ai prodotti locali.
Il futuro del Distretto del Cibo è in bilico. Schiacciato tra l’indispensabile rinnovamento generazionale delle risorse umane impegnate nelle aziende agricole, le piccole dimensioni aziendali, la necessità di raggiungere sostenibili economie di scala.
L’aumento delle dimensioni produttive da perseguire con l’accorpamento dei terreni oppure con l’associazionismo aziendale. Il rafforzamento della rete di stoccaggio, di trasformazione, di distribuzione, di commercializzazione. La zona oggi si distingue in tre aree con forti integrazioni fra di loro e con le zone limitrofe. Il Chierese con il Pia- nalto, il Nord Astigiano, il Chivassese, il Monferrato e il Torinese. Il Carmagnolese con il Pianalto, il Roero, il Braidese, il Saluzzese-Saviglianese, il Basso Pinerolese, il Carignanese e il Torinese. Il Pianalto con il Chierese, il Carmagnolese, il Monferrato, il Roero e il Torinese.
Lunedì 5 giugno, a Chieri, alla presenza di molti sindaci, amministratori, associazioni di produttori, sono state discusse alcune proposte per il lancio ed il rilancio del Distretto del Cibo. Come affermato da Pasquero, coordinatore Italia Viva del Chierese e Carmagnolese: “Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese è un progetto di sviluppo, che ha unito un territorio di 25 Comuni e 145.000 residenti intorno al cibo e si trova ora di fronte ad un bivio: ritrovare e rafforzare i suoi principi ispiratori o rinunciarvi”.
► Ciliegie e amarene hanno tanto in comune, e tante differenze (31/5/2023)
Rosse, bellissime allegre: ciliegie e amarene hanno molte cose in comune, ma non sono lo stesso frutto. La differenza tra ciliegia e amarena, infatti, è ben definita sia dal punto di vista botanico che da quello del gusto. Questo vuol dire che le ricette e le occasioni per gustare l’una e l’altra si moltiplicano in infinite possibilità sane e golose.
Differenze botaniche: frutti e alberi di amarene e ciliegie. Seppur somiglianti e appartenenti alla stessa famiglia, i ciliegi e gli alberi di amarene sono differenti.
Ciliegie e duroni, infatti, sono il frutto del Prunus Avium, anche conosciuto come ciliegio dolce, del quale esistono molte varietà. Solo in Italia se ne contano circa venti: la Moretta di Vignola IGP, le Ferrovia e la ciliegia di Marostica, solo per nominare le più conosciute.
Il Prunus Cerasus (ciliegio aspro), invece, è la pianta che produce amarene, visciole e marasche. Ad uno sguardo attento, tra amarena e ciliegia ci sono anche differenze d’aspetto: in genere le prime sono più piccole e anche la tonalità di rosso, sempre bellissima, è più tenue e delicata inoltre tra amarene e ciliegie ci sono differenze di gusto e di consistenza.
La ciliegia ha infatti polpa abbondante e succosa mentre l’amarena è più soda e ha un sapore con toni più aspri e amarognoli. Se le ciliegie sono ottime per torte morbide e focacce dolci, il gusto intenso dell’amarena è particolarmente indicato per realizzare sciroppi, liquori e confetture come il famoso Maraschino, o la marmellata di visciole, essenziale per preparare la crostata romana con la ricotta.
Amarena di Trofarello PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali
Le amarene di Trofarello sono frutti freschi della specie Prunus Cerasus, a polpa acidula tenera e trasparente. Le amarene in lingua piemontese sono chiamate “griote”.
Nell’areale del Pianalto, di cui abbiamo detto in articoli precedenti, sono per lo più diffuse vecchie varietà o cloni affermatisi localmente e coltivati secondo tecniche frutticole ecosostenibili o biologiche; le amarene sono raccolte al giusto grado di maturazione, scelte e confezionate secondo la normativa in vigore e secondo le richieste del mercato.
Tra le varietà affermatesi vi è l’amarena Marisa o Barbero che è una cultivar di ciliegio acido con caratteri intermedi tra l’amarena e la ciliegia dolce, con picciolo lungo con un frutto più grosso dell’amarena classica, di colore rosso scuro e sapore dolce-acidulo, con lieve retrogusto amarognolo. L’amarena di Trofarello ha una maturazione ritardata rispetto alla ciliegia ed ai graffioni, tanto che la raccolta dei frutti dura fino alla metà di luglio. Fra i limiti delle amarene di Trofarello vi sono quelli della sua non elevata resistenza alle manipolazioni ed alla conservazione e la vulnerabilità ad attacchi precoci di Ragoletis cerasi.
Zona di produzione: La zona di produzione è limitata ai comuni di Trofarello e di Moncalieri (TO).
La storia: La coltivazione della ciliegia e dell’amarena nelle Colline Torinesi si è diffusa all’inizio del Novecento in sostituzione, sia fisica dei vigneti rovinati dalla peronospora, sia reddituale per le famiglie degli agricoltori. Una notevole espansione della coltivazione ceresicola si è poi avuta a seguito della distruzione dei vigneti da parte della filossera, comparsa nella collina torinese nel 1925.
Mentre a Pecetto, all’inizio del secolo, si sviluppava la coltivazione delle ciliegie dolci da tavola, a Trofarello si è mantenuta la prevalenza originaria della coltivazione delle amarene con un proprio mercato specializzato nelle amarene e funzionante fino al 1989. La destinazione principale delle amarene di Trofarello, prima della chiusura del mercato specializzato, erano l’Emilia Romagna, Genova ed alcune industrie alimentari locali. Le amarene di Trofarello erano ricercate in tutta Italia, tanto da attrarre compratori che venivano ad acquistare il prodotto anche da altre regioni. Secondo testimonianze orali dei produttori, negli anni dal 1950 al 1965, circa 300 “ciresè” (raccoglitori di ciliegie e amarene, provenienti dalle zone montane o dalle colline limitrofe) venivano a Trofarello nella stagione della raccolta e si fermavano per circa un mese o un mese e mezzo.
Italo Eynard e Roberto Paglietta in “Indagine pomologica sulle cultivar di ciliegio della provincia di Torino”, pubblicata negli Annali dell’Accademia di Agricoltura di Torino, anno 1965, scrivono che l’amarena “si sta diffondendo in provincia di Torino, particolarmente nelle zone di Trofarello e Revigliasco ove costituisce circa l’80% dei nuovi impianti”, poiché “è cultivar molto produttiva e ricercata dall’industria conserviera”. Siccome non risulta che dopo il 1980 siano stati fatti nuovi impianti di alberi di amarene a Trofarello ed a Revigliasco, è ipotizzabile che questa coltura sia destinata a contrarsi ulteriormente, acquisendo un carattere meramente familiare.
Tutela legislativa: L’amarena di Trofarello è classificata come “Prodotto agroalimentare tradizionale del Piemonte”, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, del Decreto Ministeriale n. 350 dell’8 settembre 1999. Data la delicatezza dei frutti che mal si prestano alla conservazione, alcune famiglie di produttori a partire dagli anni ‘70 decisero di organizzare un fiera che permettesse di vendere alla sera i frutti raccolti in giornata.
La tradizione e’ arrivata fino ai giorni nostri ed ogni anno in giugno a Trofarello ha luogo questo evento.
► Dalla Mesopotamia a Santena: la storia di sua maestà l’Asparago (17/5/2023)
A Santena va in scena la 90a Sagra dell’asparago e quindi pensiamo sia utile conoscere alcuni aspetti dell’Asparago Santenese e delle Terre del Pianalto, è un tenero germoglio, dalle proprietà essenziali esaltate dalla freschezza e velocità con le quali passa dal campo alle tavole. Il marchio di qualità (PAT prodotto Agroalimentare Tradizionale) certifica la provenienza con i dati della cascina che lo coltiva. L’asparago è forza della natura: è il primo ortaggio a spuntare nell’orto (tra fine marzo e inizio aprile) e si sa che non ama il vento, il freddo e la troppa umidità. Quando c’è il giusto equilibrio climatico, la punta della gemma sotterranea in poche ore si fa largo nella terra sabbiosa e morbida puntando verso il cielo alla ricerca dei raggi solari. In due giorni il germoglio sarà pronto: il contadino con delicatezza deve reciderlo sotto la linea del terreno per poi posarlo nel cesto. La specialità degli asparagicoltori di Santena sta nella maestria e nel tempismo con cui compiono l’operazione e la filiera corta consente di portarlo in tavola nell’arco di poche ore, massimo entro due giorni. Si dice che così, appena raccolto, amasse consumarlo il più noto dei coltivatori ed estimatori dell’asparago santenese: Camillo Cavour che a Santena ha la sua casa e la sua tomba. Il ciclo vitale di questo ortaggio è intrecciato indissolubilmente con Cavour e Santena. Cavour ne apprezzava talmente tanto il germoglio da chiedere, nel 1847, ai migliori esperti di trovare il modo per garantirne prosperità e abbondanza sui propri terreni ed in tutta la zona. Da allora non sono sempre state rose e fiori: circa 20 anni fa un gruppo di santenesi coltivatori, preoccupati perché la produzione languiva e la redditività calava, interpellarono i migliori specialisti perché intervenissero per restituire il prezioso ortaggio alle sue terre. Dopo tanto lavoro, esperienze e fatiche oggi il germoglio è tornato in buona salute e fa onore alle tavole.
UN PO’ DI STORIA. Pare che la coltura dell’asparago abbia avuto origine nella valle dell’Eden (Mesopotamia), diffondendosi nell’antico Egitto e in Asia Minore oltre 2000 anni fa, e poi in tutto il Mediterraneo. I Romani già dal 200 a.C. lo citavano nei loro manuali. Il termine asparago deriva dal latino asparagus, a sua volta dal persiano asparag, cioè germoglio. Dal XV secolo è iniziata la coltivazione in Francia, per poi giungere nel XVI secolo all’apice della popolarità anche in Inghilterra. Successivamente fu introdotto in Nord America prevalentemente per usi officinali. In Veneto l’origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani. L’utilizzo dei fusti sembra risalga al Cinquecento, allorché, dopo una violenta grandinata che distrusse la parte aerea delle piante, cercando di salvare almeno la parte bianca che rimaneva sottoterra, ci si accorse che era anch’essa molto buona. Alla forma fallica e al fatto che i turioni hanno una crescita velocissima si ricollega la credenza antica che gli asparagi siano un cibo afrodisiaco.
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI. E’ ricchissimo di Asparagina, uno degli amminoacidi che serve alla sintesi proteica di rutina che serve a rinforzare le pareti dei capillari e di Acido folico, che serve nel metabolismo del ferro e dell’emoglobina. Ha un eccellente contenuto di fibre ma solo 25 Kcal/100! Alcuni dei componenti dell’asparago sono metabolizzati ed espulsi tramite l’urina, dandole un tipico e forte odore da alcuni ritenuto sgradevole. Esso in particolare è causato da alcuni prodotti di degradazione contenenti zolfo che però non sarebbero prodotti da tutti gli esseri umani. Infatti, secondo alcuni studi inglesi, la via metabolica che produce le molecole che determinano il caratteristico avviene solamente nel 40% delle persone.
► Inizia da Cambiano da debacle delle Brigate Rosse (3/5/2023)
Oltre alle storiche memorie, il Pianalto può raccontare anche un episodio di grande rilevanza sconosciuto ai più che ebbe luogo nella caserma dei Carabinieri di Cambiano.
Febbraio 1980, sono gli anni cupi del terrorismo rosso; i brigatisti hanno rapito e ucciso Moro due anni prima, poi è stata la volta del sindacalista Guido Rossa, del giudice Emilio Alessandrini, del giornalista Walter Tobagi, dell’attacco alla Scuola di Amministrazione aziendale di Torino. Lo Stato, messo alle corde, si è affidato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, posto a capo di una struttura investigativa speciale, e ha approvato una legge che garantisce sconti di pena a chi si dissocia dall’eversione e collabora con la giustizia.
Il 18 febbraio 1980 viene arrestato a Torino Patrizio Peci, membro della direzione strategica delle BR. Le opportunità offerte dalla legislazione si incontrano con un ripensamento avviato nell’ultima fase della militanza, e Peci lascia intendere di essere disposto a collaborare.
Bisogna però essere cauti molto cauti se si vuole che al primo “brigatista pentito” ne seguano altri. Non si deve fallire e le cautele sono d’obbligo.
Per fare in modo che gli altri detenuti delle “Nuove” non si accorgano della sua disponibilità a collaborare notandone l’assenza (davanti ai magistrati i terroristi si dichiarano prigionieri politici e l’interrogatorio finisce subito), Peci viene ufficialmente trasferito in un carcere delle Marche, sua regione d’origine (nasce a San Benedetto del Tronto nel 1953) ma in realtà viene portato nella caserma dei Carabinieri di Cambiano, dove avviene l’incontro con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giudice Giancarlo Caselli.
Quarantott’ore di confessioni, tra innumerevoli caffè per mantenersi lucidi, appunti di nomi e circostanze, verbali redatti. Il pentito è preciso, è addentro alla struttura verticistica delle BR e conosce molto bene meccanismi, uomini, azioni. Le sue rivelazioni permettono di infliggere un colpo durissimo all’organizzazione brigatista: nelle settimane successive vengono smantellate le colonne di Genova e Torino, arrestati 66 terroristi, fermato Roberto Sandalo (che a sua volta collabora permettendo di identificare 72 militanti di Prima Linea).
Il terrorismo rosso sconfitto a Cambiano, nel Pianalto? Affermarlo sarebbe una forzatura: ricordare l’episodio significa però far luce su un momento decisivo della battaglia tra la legalità democratica e l’eversione brigatista. Come ricorda Giancarlo Caselli, “le 48 ore di interrogatorio a Cambiano hanno segnato davvero una svolta”.
► Tullitullitullipan, arriva dall’Asia il fiore simbolo del Pianalto ( 5/4/2023)
Messer Tulipano 2023 torna al Castello di Pralormo per una nuova grande edizione, la ventiduesima della sua storia. Si rinnova dunque anche per il 2023 l’appuntamento con la manifestazione floreale che si svolge dal 1° aprile al 1° maggio 2023. Come ogni primavera, nella splendida tenuta nobiliare, ad appena trenta chilometri da Torino sbocceranno oltre 100.000 tra tulipani e narcisi che daranno il benvenuto alla bella stagione nel parco progettato nel XIX secolo da Xavier Kurten, architetto di corte e autore dei più importanti giardini delle residenze sabaude.
Cosa sappiamo dei tulipani?
Il loro nome deriva dal turco tülbent, “turbante”, per la forma che il fiore sembra rappresentare e che ha avuto origine nei monti del Pamir e nelle montagne dell’Hindu Kush e del Tien Shan (Asia centrorientale); si è esteso poi al Nordafrica, Grecia, Balcani, Turchia, Siria, Israele, Territori Palestinesi, Libano, Giordania, Iran. A nord è arrivato fino all’Ucraina e alla Siberia e Mongolia, ad est si è spinto fino in Cina.
Ebbe una grande popolarità in Turchia nel XVI secolo durante il regno di Solimano il Magnifico, che lo volle sviluppare in numerose varietà che impiantò ovunque nei territori del suo regno. Fu portato per la prima volta in Europa nel 1554 dal fiammingo Ogier Ghislain de Busbecq, ambasciatore di Ferdinando I alla corte di Solimano il Magnifico, che ne spedì alcuni bulbi al botanico Carolus Clusius, responsabile dei giardini reali olandesi. La sua coltivazione nei Paesi Bassi iniziò all’incirca a partire dal 1593. I tulipani divennero così rapidamente una merce di lusso e uno status symbol e crebbero rapidamente di prezzo. Dai loro scambi commerciali nacque tra il 1634-37 la prima bolla speculativa documentata della storia del capitalismo, la famosa bolla dei tulipani, che esplose il 5 febbraio 1637.
I territori del Pianalto sono particolarmente adatti alla coltivazione di questo fiore che necessita di terreni sabbiosi, arricchiti con compost e ben drenati. I bulbi (interrati a circa 10-20 centimetri di profondità e distanti tra loro 15-20 centimetri), devono essere annaffiati ogni due o tre giorni nei periodi in cui non si verificano piogge, evitando sempre la formazione di ristagni d’acqua. Le piante di tulipani non hanno bisogno di particolari cure e non vengono facilmente attaccate da parassiti, ma temono le muffe, che possono farle marcire; fioriscono a partire dalla primavera.
La bolla dei tulipani o tulipomania è stata una bolla speculativa sui prezzi dei bulbi dei fiori scoppiata nell’economia olandese del Seicento, forse la prima documentata nella storia del capitalismo. Nella prima metà del XVII secolo, nei Paesi Bassi la domanda di bulbi di tulipano raggiunse un picco così alto che ogni singolo bulbo di tulipano raggiunse prezzi enormi (sopra a 200 fiorini olandesi); questo straordinario livello dei prezzi calò drasticamente in breve tempo.
A partire dal 1636, il bulbo di tulipano diventò il quarto principale prodotto di esportazione dei Paesi Bassi dopo gin, aringhe e formaggio. Il prezzo salì alle stelle a causa della speculazione fra coloro che non avevano mai visto i bulbi. Molte persone ottennero e persero la loro fortuna da un giorno all’altro.
Forse pochi sanno che il tulipano è il simbolo delle relazioni perfette ed equilibrate, innalzandosi quindi a simbolo di vero amore. Questo perché, secondo un’antica leggenda, il tulipano nasce dalle gocce di sangue di un uomo, Ferhad, che si tolse la vita per amore di una donna.
Quali tulipani regalare?
Chi regala tulipani bianchi vuole chiedere perdono.
I tulipani gialli: portano con sé la volontà di illuminare una giornata con un sorriso.
I tulipani variegati nel linguaggio dei fiori sono un complimento per la bellezza degli occhi di chi li riceve.
I tulipani rosa: simboleggiano l’amore affettuoso e fraterno.
Il tulipano nero indica passione, sensualità ed erotismo. Come regalo floreale, i tulipani neri sono quindi riservati solo alle coppie che provano principalmente affetto sensuale l’uno per l’altro.
► Ciliegi, peri, gelsi piante emblematiche (22/3/2023)
Il Pianalto è un territorio ricco di vegetazione e come tale favorisce la coltivazione di alcuni alberi, che offrono frutti particolari, che connotano l’area in cui viviamo.
A Pecetto, Revigliasco e Valle Sauglio c’è “ciliegia”, che ha avuto un passato tormentato a causa della “peronòspora”, una malattia delle piante che nel 1899 si abbatte sui vigneti di freisa: un fungo che attacca i pampini e i grappoli, e che le conoscenze scientifiche dell’epoca non riescono in nessun modo a contrastare, distrugge nel giro di due/tre stagioni la tradizionale risorsa agricola del territorio.
Che fare? I contadini si riuniscono con gli uomini di riferimento della comunità (parroci, sindaci, notabili) e studiano soluzioni. C’è chi propone di tornare all’antico e sostituire le viti con i gelsi sviluppando l’allevamento dei bachi da seta; qualcun altro, più attento all’evoluzione del mercato, suggerisce le piantagioni di pere, richieste per la preparazione della caratteristica grappa profumata e dei vini aromatici (proprio a Pecetto, nel 1757, la famiglia Cinzano aveva iniziato l’attività di distillazione). Nessuna soluzione persuade: l’allevamento dei bachi da seta suscita dubbi commerciali perché ha già altri centri di produzione nell’area torinese; la grappa alle pere scatena invece diffidenze morali perché pare un incentivo all’alcolismo.
La soluzione arriva dall’impegno del giovane avvocato pecettese Mario Mogna e del dinamico viceparroco don Michele Marchetti: puntare su una coltivazione agricola esclusiva, trasformando la collina in una grande piantagione di ciliegi. Il terreno è adatto e la storia passata conforta: nel XVII secolo il ciliegio acido selvatico o amarena (la “griota”) era abbondante all’Eremo e i padri Camaldolesi lo utilizzavano sia per il consumo diretto, sia per ricavare dai gambi essiccati un rimedio contro la ritenzione d’urina.
L’orientamento dell’avvocato Mogna e di don Marchetti trova sostegno nella politica agricola di Giovanni Giolitti (presidente del Consiglio dal 1902 al 1914) che promuove la diffusione di colture specializzate a reddito certo. Il dinamismo dei promotori e la loro capacità di persuasione, uniti ai sostegni statali, convincono la maggior parte dei piccoli proprietari terrieri a piantare ciliegi e la scommessa si rivela vincente.
Nel 1911, in occasione dell’Esposizione Universale di Torino per il 50° dell’Unità d’Italia, ragazze in costume offrono ciliegie “in composta” ai visitatori che si aggirano tra i padiglioni del Valentino; la città diventa presto un mercato che assorbe quantità significative del nuovo prodotto; nel 1915 il Consiglio Comunale di Pecetto decide di regolamentare la vendita e stabilisce un mercato a ora fissa nella piazza antistante la Chiesa. In quindici anni, dal flagello della peronòspora si passa così alla celebrazione della ciliegia di Pecetto (e subito dopo dell’amarena di Valle Sauglio-Trofarello).
► I personaggi illustri della storia tra il profano e il sacro (8/3/2023)
Uno sguardo retrospettivo permette di rintracciare un denominatore comune: nel corso del XIX secolo il Pianalto è stata la terra della “modernità politico-sociale” piemontese (e, dunque, italiana), perché è stata la terra dei “padri fondatori” dell’unità nazionale e la terra dei “santi sociali”: i primi hanno realizzato il processo del Risorgimento (modernizzazione politica), i secondi hanno affrontato il problema dell’aggregazione del tessuto sociale in epoca di industrializzazione (modernizzazione sociale). Lo sforzo rivolto a creare un’identità del Pianalto deve dunque partire da queste due chiavi di lettura.
PADRI FONDATORI
La figura centrale è ovviamente Camillo CAVOUR, che la storiografia dell’ultimo ventennio sta indagando e rivalutando nel carattere multiforme della sua attività: imprenditore agricolo, diplomatico di respiro europeo, statista capace di progettare il futuro, laico senza essere anticattolico. Attorno a lui vanno però riscoperti e valorizzati personaggi a diverso titolo legati al Pianalto: PROSPERO BALBO (1762-1837), chierese, ministro, presidente perpetuo dell’Accademia delle Scienze e della Regia Deputazione di Storia Patria; il figlio CESARE BALBO (1789-1853), presidente del Consiglio nel 1848, fondatore con Cavour de’ “Il Risorgimento”.
FAMIGLIA THAON DI REVEL DI SANT’ANDREA, legati a Ternavasso e Poirino, con i conti GIUSEPPE (1756-1820), primo comandante dei Reali Carabinieri, OTTAVIO (1803-1868), cofirmatario dello Statuto Albertino, PAOLO (1856-1948), il Grand’Ammiraglio della Grande Guerra consigliere e amico del re Vittorio Emanuele III.
CONTI DI PRALORMO, tra cui CARLO BERAUDO (1784-1855), diplomatico negoziatore della pace con l’Austria nel 1849, ed EMANUELE (1887-1960), generale e cavaliere, vincitore a Parigi nel 1924 di una delle prime medaglie olimpiche italiane Pecetto nella villa Nigra (ora villa Sacro Cuore), talvolta con Virginia Oldoioni CONTESSA DI CASTIGLIONE (1837-1899).
LUIGI MAROCCO, noto come FRATE GIACOMO da Poirino (1808-1885), confessore di Cavour. GLI ALFIERI DI SOSTEGNO e i VISCONTI VENOSTA, in stretta relazione con Camillo Cavour.
SILVIO PELLICO, ospite spesso a Pecetto nella villa Talucchi-Pallavicini con l’attrice di teatro Teresa Bartolozzi “Gegia”.
Accanto ai personaggi vanno valorizzati i “momenti”: in questo senso sono centrali il “PROCLAMA DI MONCALIERI” del 1849 (e tutte le presenze politicamente significative nel castello), i FUNERALI DI CAVOUR a Santena nel 1861, gli amori nel castello di Moncalieri tra Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana “Bela Rosin” e quelli tra Laetitita Bonaparte (figlia di Clotilde di Savoia e Gerolamo Bonaparte) e il filosofo tedesco Nietzsche nel 1888-89, la presenza di Vittorio Emanuele III a Ternavasso nel giugno 1940 durante la campagna di Francia.
SANTI SOCIALI
La figura centrale è GIOVANNI MELCHIORRE BOSCO meglio noto come DON BOSCO (1815-1888) di Castelnuovo, fondatore dei Salesiani e all’origine di un orientamento pedagogico volto ad istruire i figli delle classi più umili per trasformarli non solo in cattolici osservanti, ma in “cittadini” consapevoli dei propri doveri e diritti.
GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO (1756-1842), nato a Bra e morto a Chieri (dove si è ritirato in casa del fratello sacerdote), fondatore della “Piccola casa della Divina Provvidenza” per assistere i malati indigenti GIUSEPPE CAFASSO (1811-1860), come Don Bosco originario di Castelnuovo, conosciuto come il “prete della forca” per l’assistenza fornita a condannati e carcerati.
GIUSEPPE ALLAMANO (1851-1926), anch’egli di Castelnuovo, rettore del Santuario della Consolata e fondatore dell’“Istituto Missioni della Consolata” attivo in Paesi africani e sudamericani.
Monsignor GIUSEPPE MARELLO (1844-1895), cresciuto a San Martino a Alfieri, fondatore della congregazione degli Oblati di San Giuseppe e vescovo di Acqui.
DOMENICO SAVIO (1842-1857), di Riva di Chieri, allievo preferito di Don Bosco, canonizzato nel 1954.
Accanto ai Santi Sociali originari del territorio, possono essere valorizzate altre due figure strettamente legate a Don Bosco: LEONARDO MURIALDO (1828-1900), originario di Torino ma stretto collaboratore di Don Bosco nella creazione dei primi oratori e fondatore del “Collegio degli Artigianelli”.
SUOR MARIA DOMENICA MAZZARELLO (1837-1881), originaria di Mornese (AL) ma stretta collaboratrice di Don Bosco, fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Quando 10.000 anni fa la temperatura s’innalzò… (22/2/2023)
Il Pianalto di Poirino e la Collina Chierese formano l’unico bacino idrografico in sponda destra del Po che non è alimentato da acque provenienti da torrenti e fiumi alpini o appenninici. Dal fatto di dipendere dalle sole precipitazioni atmosferiche derivano gli storici problemi di carenza d’acqua di questo territorio ai quali si è sopperito costruendo invasi, peschiere, canali, fossi e numerosi pozzi che pescano nelle falde acquifere sotterranee.
Quando circa 10.000 anni fa ci fu un periodo di innalzamento della temperatura terrestre, lo scioglimento del ghiacciaio, che dalle Alpi si estendeva fino alla collina di Moncalieri costituendo una gigantesca barriera delimitante il territorio con la sua idrografia, determinò l’assetto territoriale che la provincia di Torino ancora oggi conosce. Numerose specie animali e vegetali si estinsero, la preziosa acqua del Po cambiò direzione tracimando le sue acque sulle terre del torinese aggirando però la collina chierese. Quei pochi metri di dislivello tra Villanova e Santena fecero la differenza perché consentirono all’attuale fiume Banna di scorrere da Est a Ovest, mentre il Po scorre da Ovest a Est.
Il Pianalto, caratterizzato da terre argillose alternate da strisce di finissime sabbiose racchiuse tra la Collina Chierese, il Monferrato, il Roero lentamente prese forma, modellato dalle acque della Banna e dei suoi affluenti.
Da una radicale trasformazione naturale, dovuta al cambiamento climatico, nasceva così il nucleo centrale del territorio che corrisponde grosso modo oggi al Distretto del Cibo.
L’argillosità e sabbiosità del terreno favoriscono la crescita e la maturazione di alcuni ortaggi rispetto ad altri caratterizzando così dal punto di vista agroalimentare quest’area che, pur caratterizzata da numerosi elementi si similitudine e connettività, pare non esserne consapevole.
IL BANNA
Il Banna è un torrente che scorre nelle provincie di Asti e di Torino. Affluente di destra del fiume Po, si getta in esso appena a monte della confluenza in quest’ultimo del Tepice.
Tepice e Banna, anche se hanno bacini idrograficamente indipendenti, per la loro vicinanza e per le caratteristiche geografiche simili vengono spesso analizzati insieme nei documenti ufficiali di pianificazione idrica.
Percorso
Il Banna, dal quale prende il nome la magnifica tenuta dei marchesi Spinola sita al confine tra Poirino e Villanova d’Asti, nasce a circa 300 m s.l.m. da un ramo chiamato Rio Bannetto, sorgente che sgorga tra le colline di Buttigliera d’Asti. A Sud raggiunge Villanova d’Asti dove transita nei pressi dell’uscita dell’autostrada Torino-Piacenza, poi deviando verso Ovest, arriva in provincia di Torino. Appena a Nord di Poirino riceve da l’apporto del Rioverde e, attraversato l’abitato di Santena, scorre tra i Comuni di Cambiano, Moncalieri e Villastellone dove riceve l’importante apporto idrico dal Rio Stellone.
Confluisce infine nel Po poco a Sud di Bauducchi.
Elementi critici
Il corso del torrente è particolarmente inquinato. L’indice di Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA) nel 2002 è stato rilevato come “scadente” nelle stazioni di rilevamento di Poirino e di Moncalieri, e l’ittiofauna risulta quasi assente per gran parte del suo corso. Il Banna ha anche causato vari eventi alluvionali: l’ultimo nel 1994 quando il torrente ha invaso varie zone di Poirino e Santena, provocando anche un decesso.
Sono terminati poco più di due anni fa i lavori di messa in sicurezza dal rischio eventi alluvionali decisi dalle autorità locali all’indomani dell’alluvione.
► Luogo ricco di eccellenze ma ancora poco conosciuto (8/2/2023)
Pianalto, potremo dire, questo sconosciuto. Il toponimo ha sicuramente un significato per chi vi è nato e cresciuto; per quelli (e sono molti) che in questo territorio si sono trasferiti nel corso degli anni è un termine spesso orecchiato ma raramente contestualizzato; per tutti gli altri, invece, è una definizione geografIca senza riferimenti chiari.
A differenza di quanto accade per le Langhe, il Roero o il Monferrato, che nell’immaginario collettivo rinviano a realtà specifiche, il Pianalto non evoca né un ambiente agricolo, né una tradizione storica, né una caratteristica enogastronomica.
Eppure il Pianalto esiste. Il territorio esteso tra la periferia sudoccidentale di Torino, un quadrilatero irregolare con i vertici a Carmagnola, Pralormo, Moncalieri e Chieri, costituisce un’area ricca di colture d’eccellenza, omogenea dal punto di vista ambientale, attraversata da memorie e tracce di un passato dinamico. Ciò che gli manca è la “riconoscibilità”: si conoscono le singole realtà cittadine, ma non l’insieme. “Costruire il Pianalto”, ecco lo sforzo all’interno del quale si inserisce questa rubrica: “costruirlo” nel senso di rintracciarne gli elementi connettivi, le caratteristiche orografiche-naturali-territoriali, le produzioni agricole, l’identità storico-culturale ereditata dal passato.
Non si tratta di un’operazione estemporanea: la creazione del “Distretto del cibo” rappresenta, sotto il profilo produttivo e commerciale, un passo impor- tante nella stessa direzione.
La rubrica può offrire spunti nuovi: elementi di conoscenza, curiosità, profili di personaggi.
Nella percezione comune un territorio esiste come realtà definita solo in quanto sa raccontarsi. Al “Pianalto” tutto questo è mancato.
Poteva essere conosciuto come la terra di Cavour; oppure come la terra dei santi sociali; oppure come la terra dei peperoni, degli asparagi, delle ciliegie; op- pure come la terra della prima ferrovia piemontese.
Oppure può sforzarsi di farsi conoscere oggi come l’insieme di tutti questi elementi. L’identità è sempre il frutto di stratificazioni nelle quali si sommano gli sforzi di molte generazioni, ognuna delle quali apporta il contributo legato al suo tempo e alle sue sfide. Non si tratta di inventare nulla: si tratta semplicemente di leggere il nostro territorio, imparando insieme a conoscerlo e a farlo conoscere.
Antonella Pannocchia
Chi è Antonella Pannocchia
Antonella Pannocchia è una studiosa e un’appassionata del territorio. E’ laureata in Biologia, con specializzazioni in Biochimica Clinica, in Patologia Generale e in Igiene di Sanità pubblica e territorio. E’ stata direttore del Dipartimento Torino di Arpa Piemonte.
E’ docente di biochimica dell’alimentazione, presso scuola per dietisti Molinette, e Docente di igiene del territorio, delle acque e degli alimenti all’Università di Torino.
E’ stata relatrice a convegni nazionali e internazionali; è autrice di numerosi articoli sulla sostenibilità ambientale.
Ha raccolto l’invito a collaborare dalla direzione de il Mercoledì e da questa settimana, con cadenza, quindicinale, tratterà temi sul territorio del Pianalto.








Condividi